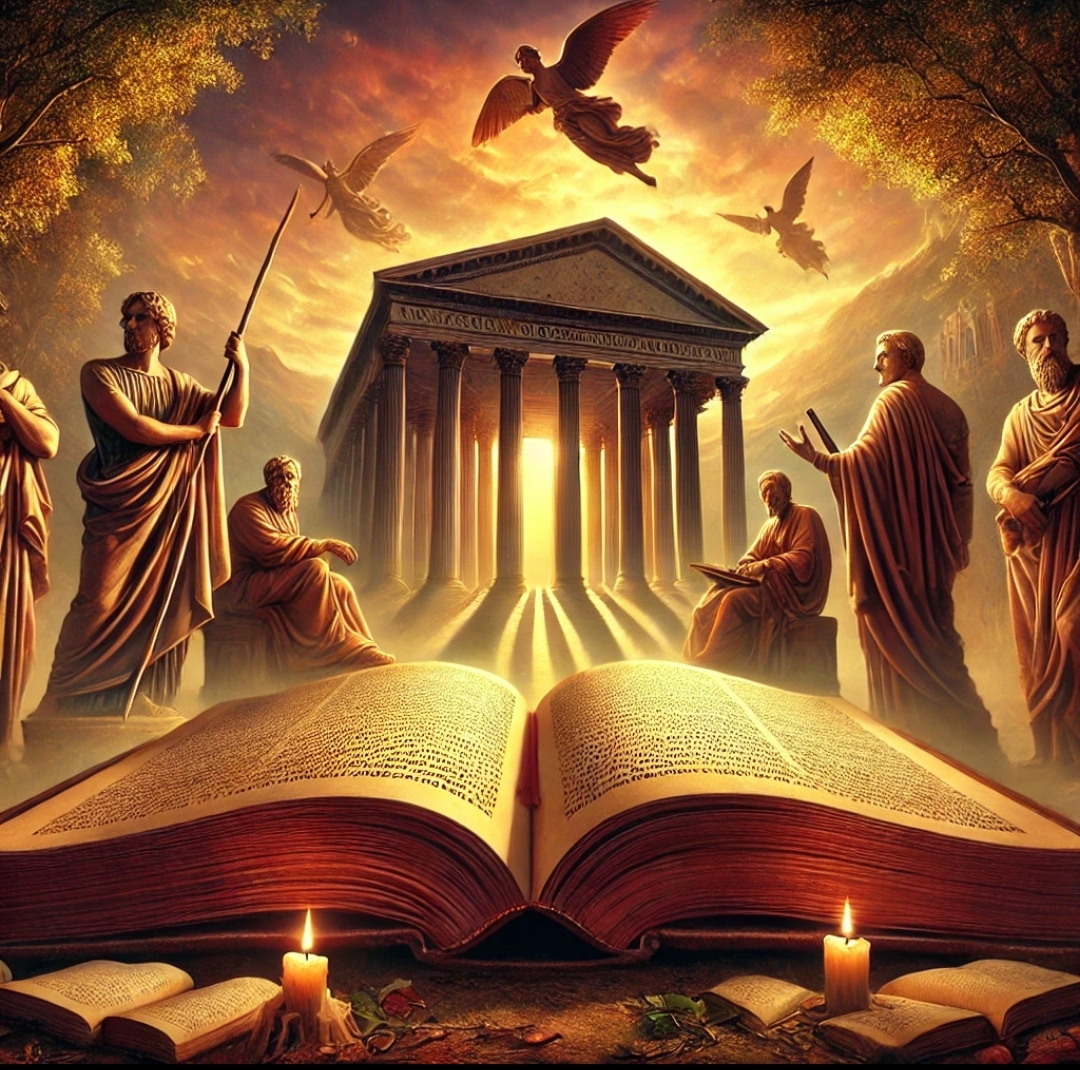*di MATTEO MULÈ.
Dalla “Rubrica Classici”.
Attraverso questo articolo si cerca di riflettere sul concetto di “classico” nella letterature e di creare una piccola rubrica in cui dare voce a quegli autori che rimangono fuori da questa etichetta, ma che riteniamo importanti per la nostra formazione sia personale che culturale.
Cosa rende effettivamente un libro un “classico”? La sua importanza? La sua unicità? Il prestigio? La grandezza del suo autore? L’impatto storico e sociale del l’opera? O forse il fatto che si tratta soprattutto di opere e autori trattati e studiati all’interno delle mura scolastiche, ritenute fondamentali per la formazione culturale dello studente e futuro cittadino di una nazione. Dante da tutti è definito il classico per eccellenza, studiato da ogni generazione nel bene o nel male e del quale anche lo studente meno interessato possiede delle nozioni di base in relazione alla sua opera più importante, ovvero la Divina Commedia. Tendenzialmente ognuno conosce la struttura della Commedia, sa che è composta da tre cantiche chiamate Inferno, Purgatorio e Paradiso, e ricorda, magari, anche alcuni versi, di solito quelli iniziali: “Nel mezzo del cammin di nostra vita mi ritrovai per una selva oscura, chè la diritta via era smarrita”. Sentendo queste parole ogni italiano riconoscerà di aver a che fare con il grande poeta toscano, il padre della nostra letteratura.
Ma che cosa ha reso Dante un classico? Di questo si potrebbe parlare per ore e tutt’oggi ogni critico letterario porta avanti la sua tesi: c’è chi dice per il suo stile, chi sostiene per il suo impatto culturale nelle generazioni a lui successive, chi afferma invece che fu il primo a elevare il volgare a lingua letteraria. Come dicevo prima si può andare avanti per giorni a discutere, ma, probabilmente, il motivo principale perché è stato comunemente deciso dalla scuola italiana, in particolar modo dal sistema elaborato da Giovanni Gentile (negli anni ‘20 del Novecento), il quale tutt’oggi rimane il modello di riferimento nell’istruzione pubblica. Io non dico e non sosterrò mai che Dante non vada studiato, anzi il contrario, ma non si può ridurre un poeta o uno scrittore ad una semplice etichetta o solamente come l’autore di una singola opera. Dante non è solo colui che ha scritto la Divina Commedia, ma è anche l’artista della Vita Nova, del De vulgari eloquentia, del Convivio, oltre che di diverse poesie singole raccolte sotto Le rime. Questo ragionamento si può fare per ogni scrittore della nostra letteratura, come ad esempio Leopardi. Il poeta recanatese è comunemente definito il poeta dei Canti (di cui, tra l’altro, si studiano solamente gli idilli e le canzoni finali tralasciando le prime canzoni come All’Italia o ad Angelo Mai) ed è vero, ma ha anche scritto un’opera in prosa che tratta di argomenti filosofici, ovvero le Operette morali, oltre che un poemetto eroicomico in ottave come “I Paralipomeni della Batracomiomachia“. Inoltre si deve riflettere che spesso la grandezza di un autore possa mettere in ombra altri scrittori o intellettuali a lui contemporanei. Ritorniamo al padre della nostra letteratura, il quale di solito viene inserito nei manuali scolastici all’interno del gruppo delle “tre corone del Trecento”, insieme a Petrarca e Boccaccio. Mentre di quest’ultimo ogni studente possiede la conoscenza almeno della struttura del Decameron insieme a qualche novella (di solito ser Ciappelletto o Nastagio degli Onesti), del poeta aretino si conosce ben poco (anche perché la sua lingua risulta di più difficile comprensione), pur avendo un’importanza notevole per la poesia italiana. La scoperta dell’interiorità e del dissidio interiore, un nuovo e decisivo linguaggio per raccontare l’amore, la nascita della modernità come messa in discussione del problema del bene e del male, lo sviluppo della figura dell’intellettuale umanista; una serie di temi che Petrarca affronta nelle sue opere, riprese dai poeti a lui successivi in linea temporale (pensiamo a Leopardi nella canzone All’Italia) e che rendono il poeta aretino, per la sua influenza, un classico a tutti gli effetti. Oppure perché non parlare di Ippolito Nievo, romanziere della seconda metà dell’Ottocento, autore delle Confessioni di un italiano, un romanzo storico che dipinge le sorti dell’Italia dei moti rivoluzionari dei primi decenni del XIX secolo attraverso le parole di Carlo Altoviti, eppure destinato a rimanere in secondo piano dinnanzi alla grandezza dei Promessi sposi.
Con questo non si vuole dare colpa alla scuola o ai professori, si sa che il tempo è poco e le ore di letteratura ormai vengono passate, per lo più, ad insegnare ai ragazzi a leggere con attenzione e a comprendere i testi, a causa del forte analfabetismo funzionale diffusosi via social. Un classico non per forza deve essere imposto dalla scuola, ma può essere anche un autore che ha avuto una particolare influenza nella nostra formazione personale e culturale, di cui siamo sempre disposti a consigliare la lettura ad altre persone. Attraverso questa rubrica, difatti, noi membri di Polis Futura cercheremo di dare voce a quegli autori o a quelle opere (anche straniere) che non si riescono ad affrontare a scuola, indossando per un momento le vesti dell’insegnante e tenendo delle vere e proprie lezioni, presentando quelli che per noi possono essere definiti classici.